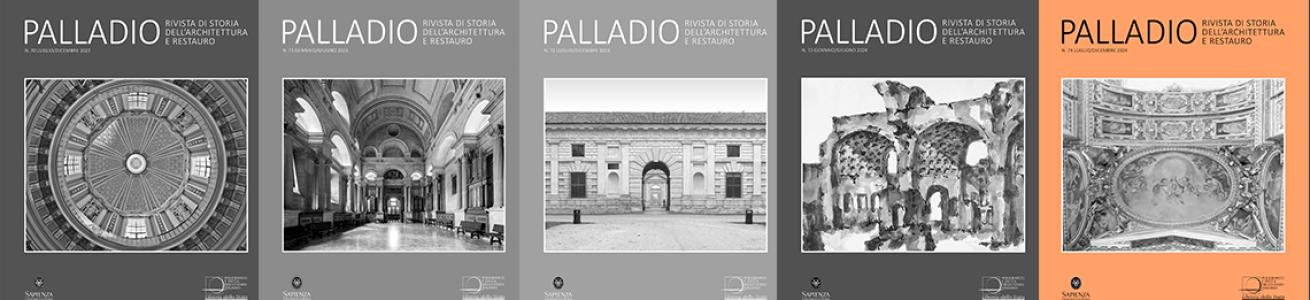In questo volume:
Iacopo Benincampi - Emanuele Gambuti, L’architettura gesuita polacco-ucraina nell’inedito portfolio di Giacomo Briano
Abstract: The discovery of a manuscript belonging to the Jesuit architect Giacomo Briano (1589-1649) has opened new avenues of inquiry into the architectural ‘modus nostrum’ promoted by the Society of Jesus during the 17th century. Dated November 19, 1621, this manuscript comprises annotated blueprints of Jesuit colleges under construction in the Polish Province of the time, encompassing present-day Poland and parts of Ukraine, including Krakow, Lublin, Łuck, Sandomierz, Lviv, Kalisz, and Poznań. These materials constitute an invaluable resource for understanding Jesuit planning and architectural practices in Central Europe during the Counter-Reformation. Furthermore, they offer a rare opportunity to deepen our understanding of the local history of several significant heritage sites, many of which are currently at risk.
Ita: La scoperta di un manoscritto appartenente all’architetto gesuita Giacomo Briano (1589-1649) ha aperto nuove linee di indagine sul “modus nostrum” promosso dalla Società dei Gesuiti nel corso del XVII secolo. Datato 19 novembre 1621, questo manoscritto è composto da piante quotate di collegi gesuiti in costruzione nell’allora Provincia Polacca, comprendente l’attuale Polonia e parti dell’Ucraina, incluse Cracovia, Lublin, Łuck, Sandomierz, Lviv, Kalisz, e Poznań. Questi materiali costituiscono una risorsa fondamentale per la comprensione della pianificazione gesuita e la pratica architettonica nell’Europa della Controriforma. Inoltre, offrono una rara opportunità di approfondire la nostra comprensione di diversi importanti siti, molti dei quali attualmente a rischio.
Marco Pistolesi, Aggiunte all’opera di Filippo Raguzzini: “Il Nuovo Seminario Romano nella città di Tivoli, et altri casini de’ particolari nell’istessa città”
Abstract: In the curriculum submitted by Filippo Raguzzini to King Charles of Bourbon of Naples in 1736, is listed the “New Roman Seminary in Tivoli,” which the author of this study identifies as the large building now housing the town’s Court. This attribution is substantiated by numerous stylistic features of the structure, which was commissioned by the Society of Jesus between 1729 and 1736—coinciding with the construction of the five palaces of Piazza Sant’Ignazio in Rome. In the second part of the article, the author examines the “other private houses in the same town” mentioned in the curriculum and identifies design elements characteristic of Raguzzini in a villa commissioned by Cardinal Giovan Battista Salerno. This villa, constructed between 1724 and 1729, is attributed to Raguzzini based on stylistic analysis and the client’s connections. Cardinal Salerno, a Jesuit, had ties to Naples and was likely associated with the circle of Pope Benedict XIII Orsini and Cardinal Nicolò Coscia, the architect’s patron. The two buildings are located a short distance from each other along the road that, leaving the main town gate. This suburban area, now irrevocably altered by 20th-century urban development, valued for its environmental and archaeological significance, was particularly popular among members of the Arcadia Academy, which included numerous Jesuit clerics.
Ita: Nel curriculum inviato da Filippo Raguzzini al Re di Napoli Carlo di Borbone nel 1736 è incluso il “Nuovo Seminario Romano a Tivoli”, che l’autore del presente studio identifica con il grande edificio che attualmente ospita il Tribunale cittadino. Quest’attribuzione è supportata da numerose caratteristiche stilistiche della struttura, commissionata dalla Società di Gesù tra il 1729 e il 1735 (in concomitanza con i cinque palazzetti di Piazza Sant’Ignazio a Roma). Nella seconda parte dell’articolo, l’autore esamina le “altre case private nella stessa città” menzionate nel curriculum e identifica elementi raguzziniani in una villa commissionata da Cardinal Giovanni Battista Salerno. Questa villa, costruita tra il 1724 e il 1729, è attribuita a Raguzzini sulla base dell’analisi stilistica e delle connessioni del committente. Il Cerdinal Salerno, un Gesuita, aveva legami con Napoli ed era probabilmente associato con la cerchia di Papa Benedetto XIII Orsini e Cardinal Nicolò Coscia, il mecenate dell’architetto. I due edifici si trovano ad una breve distanza l’uno dall’altro lungo la stessa strada, fuori dalla porta cittadina. Quest’area suburbana, irrevocabilmente alterata dallo sviluppo novecentesco, era particolarmente ambita dai membri dell’Accademia di Arcadia, che annoverava molti gesuiti, per il suo valore ambientale e archeologico.
Francesco Dafano, Mauro Fontana tra cromatismo e ricerca spaziale: la cappella dei Cavallerini in San Carlo ai Catinari
Abstract: The architectural language of Mauro Fontana reflects the geometricized and attenuated Berninism that defined the work of the Fontana family beginning with the grandfather Carlo. The Cavallerini Chapel, shaped in part by the collaboration of the entrepreneur-stonemason Francesco Cerroti, serves as a venue for experimenting with marble combinations, drawing inspiration from the classical works of the preceding generation. Francesco Valle’s 1736 manuscript offers valuable insights regarding the preexisting structures.
Ita: Il linguaggio architettonico di Mauro Fontana riflette il berninismo geometrizzato e attenuato che definì l’opera della famiglia Fontana a partire dal nonno Carlo. La Cappella Cavallerini, realizzata in parte in collaborazione con l’imprenditore-lapicida Francesco Cerroti, funge da occasione per sperimentare le combinazioni di marmi, prendendo spunto dalle opere classiche della generazione precedente. Il manoscritto di Francesco Valle del 1736 offre spunti significativi riguardo le strutture preesistenti.
Giorgia Alessandra D'Onofrio, Il Palazzo del Tribunato alla Cancelleria e l’attività di Andrea Vici per la Repubblica giacobina
Abstract: This study focuses on the analysis of several unpublished graphic works by Andrea Vici, preserved in the private Busiri Vici archive in Rome. These drawings, previously attributed to a courtroom project, are here identified as designs for the conversion of the Palazzo della Cancelleria in Rome into the headquarters of the Republican Tribunate. This commission formed part of the revolutionary process of secularization and redefinition of the civic identity of the papal city. With limited time and financial resources, the republican government entrusted the adaptation of various papal palaces into new administrative offices to professionals already active in the capital, including Andrea Vici. A closer examination of this significant project enriches our understanding of Vici’s Roman activity - less explored compared to his work in the Marche region - and, alongside other commissions for the Republic, positions the architect among the leading figures of Jacobin Rome.
Ita: Questo studio ha come oggetto l’analisi di diverse opere grafiche inedite di Andrea Vici, conservate nell’archivio privato Busiri Vici a Roma. Questi disegni, precedentemente attribuiti a un progetto per un tribunale, sono qui identificati come il progetto per la trasformazione del Palazzo della Cancelleria a Roma nel quartier generale del Tribunato della Repubblica. Questa commissione rientra nel processo rivoluzionario di laicizzazione de ridefinizione dell’identità civica della città papale. Con tempo e risorse limitate a disposizione, il governo repubblicano affidò a professionisti già attivi nella città, tra cui Andrea Vici, l’adattamento di vari palazzi papali a nuovi uffici amministrativi. Un’indagine più accorta di questo importante progetto arricchisce la nostra comprensione dell’attività romana di Vici – meno nota della sua opera nelle Marche – e, insieme ad altre commissioni per la Repubblica, pone l’architetto tra le figure di spicco della Roma giacobina.
Ambrogio Keoma, Restauro e riedizione critica del lessico architettonico: quattro chiese ferraresi
Abstract: The issue of architectural lexicon in the context of the restoration of façade colors is particularly sensitive and frequently subject to misinterpretations of the text. Ferrara exemplifies a city where historicist restorations or interventions lacking updated theoretical and methodological frameworks have systematically stripped away entire chromatic layers or obscured them with 19th- and early 20th-century applications. A series of recent post-earthquake restoration projects on churches in the area - closely monitored throughout the design and execution phases by the author in the capacity of a heritage preservation officer - has provided an opportunity to explore the topic in depth. These efforts have laid the groundwork for an approach rooted in careful stratigraphic analysis, the interpretation of the architectural text in its authenticity, and finally, its critical re- editing, based on a careful balance between the analysis of the historical material and philological study.
Ita: La questione del lessico architettonico nel contesto del restauro cromatico delle facciate è particolarmente sensibile e spesso soggetta a errate interpretazioni del testo. Ferrara è l’esempio di unna città dove restauri storicistici o interventi condotti secondo modelli di riferimento teoricamente e metodologicamente datati hanno sistematicamente strappato interi livelli cromatici, o li hanno nascosti dietri applicazioni otto-novecentesche. A seguito del terremoto, una serie di progetti di restauro sulle chiese di quest’area – attentamente monitorati dall’autore in qualità di esperto di conservazione del patrimonio – ha fornito l’occasione per approfondire l’argomento. Questi sforzi hanno creato le premesse per un approccio radicato in un’attenta analisi stratigrafica, un’interpretazione del testo architettonico nella sua autenticità, e infine la sua riedizione critica, basata su un’accorta mediazione tra analisi del materiale storico e studio filologico.
Fabrizio Di Marco, Un corso, la sua storia, i suoi metodi. Ricerche sulle cappelle gentilizie romane 1570-1620
Abstract: This short article introduces the seven contributions on Roman aristocratic chapels (1570–1620), selected from a large number of research topics assigned over the past decade in the course Storia e metodi di analisi dell’architettura, taught by the author and Augusto Roca De Amicis at the School of Specialization in Architectural and Landscape Heritage at Sapienza University of Rome. The article opens with a chronological overview of the course’s evolution from the 1970s to the present, tracing its various name changes up to its current designation, adopted in 1996. That year, Sandro Benedetti redefined the course with a stronger historical-critical emphasis, a distinctive feature that continues to characterize the approach of the current faculty.
Ita: Questo breve articolo introduce sette contributi su cappelle gentilizie romane (1570-1620), selezionati da un gran numero di argomenti di ricerca assegnati nell’ultimo decennio nel corso “Storia e metodi di analisi dell’architettura”, tenuto dall’autore e da Augusto Roca de Amicis alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio all’Università di Roma Sapienza. L’articolo apre ripercorrendo l’evoluzione del corso dagli anni ’70 al presente, attraverso numerosi cambi di nome fino alla designazione corrente adottata nel 1996. In quell’anno, Sandro Benedetti ridefinì il corso in chiave storico-critica, una caratteristica che ad oggi continua a caratterizzare l’approccio del collegio.
Claudia Lattanzi, La cappella della Santissima Trinità in Santo Spirito in Sassia
Abstract: The Chapel of the Holy Trinity occupies a position of temporal succession and programmatic iconological continuity within the Church of Santo Spirito in Sassia. The architectural integration of pictorial and sculptural languages reflects an interpretation of the prevailing experimental atmosphere, characterized by an exuberant decorative style. The artist responsible for this work is Livio Agresti, a painter associated with prestigious late Mannerist enterprises. From these, he incorporates elements of stylistic contamination, which he masterfully orchestrates in this chapel, achieving a formal synthesis with a significant perceptive impact.
Ita: La Cappella della Santa Trinità occupa una posizione di successione temporale e continuità programmatica e iconologica all’interno della Chiesa di Santo Spirito in Sassia. L’integrazione architettonica di linguaggi pittorici e scultorei riflette un’interpretazione dell’atmosfera di sperimentazione dominante, caratterizzata da uno stile decorativo esuberante. L’artista è Livio Agresti, un pittore associato a prestigiose imprese tardomanieriste. Da queste, incorpora elementi di contaminazione stilistica, che orchestra magistralmente in questa cappella, raggiungendo una sintesi formale di grande impatto stilistico.
Livia Colopardi, La cappella dell’Assunzione di Maria in Santo Spirito in Sassia
Abstract: The Chapel of the Assumption of Mary, located as the second chapel on the right upon entering the Church of Santo Spirito in Sassia, represents a significant decorative milestone for the church. This artistic endeavor took place during the pontificate of Gregory XIII, a key proponent of the artistic trends of the period. The chapel’s design exhibits strong ties to the aesthetic sensibilities of aristocratic residences, with an interplay of stuccoes and frescoes characterized by pronounced naturalistic and perspectival elements. These features evoke the collaborative artistic practices of the early 16th century, highlighting the importance of teamwork in achieving its cohesive decorative program.
Ita: La Cappella dell’Assunzione di Maria, seconda a sinistra dall’entrata nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia, rappresenta un importante snodo decorativo della chiesa. Quest’impresa artistica ebbe luogo durante il pontificato di Gregorio XIII, patrono delle tendenze artistiche dell’epoca. La cappella esibisce forti legami con le sensibilità estetiche delle residenze aristocratiche, caratterizzate dal gioco di stucchi e affreschi caratterizzati da forti elementi naturalistici e prospettici. Queste caratteristiche evocano le pratiche artistiche collaborative del XVI secolo, con il loro gioco di squadra teso alla realizzazione di un programma decorativo coerente.
Elisabetta Romano, La cappella della Madonna della Misericordia in San Giovanni dei Fiorentini
Abstract: The Chapel of Our Lady of Mercy is, for multiple reasons, exceptional among the aristocratic chapels of the Basilica of San Giovanni dei Fiorentini. Although the Archconfraternity of the Florentines designated it as a prototype for the construction of the other chapels, its distinctive iconography and the legendary history of the Marian image at its altar render it singular within the basilica. In particular, the chapel embodies key aspects of architectural language in the second half of the sixteenth century, shaped by the reformist impulses of the Council of Trent. Within this context, a new approach to the art of marble craftsmanship—central to this chapel— emerged, redefining the organization of construction sites. Stonemasons, squarers, and draftsmen assumed increasingly prominent roles, and for the first time, the building process was conceived primarily as the product of collaborative labor among skilled artisans.
Ita: La Cappella della Madonna della Misericordia è, per diverse ragioni, un’eccezione tra le cappelle aristocratiche della Basilica di San Giovanni dei Fiorentini. Sebbene l’Arciconfraternita dei Fiorentini l’avesse designata come prototipo per la realizzazione delle altre, la sua distintiva iconografia e la storia leggendaria dell’icona mariana sul suo altare la rendono unica all’interno della basilica. In particolare, la cappella esprime alcuni elementi chiave del linguaggio architettonico della seconda metà del sedicesimo secolo, modellato dagli impulsi riformisti del Concilio di Trento. In questo contesto emerge un nuovo approccio all’arte della modellazione del marmo, che ridefinisce l’organizzazione del cantiere. Lapicidi, intagliatori, e disegnatori assumono ruoli sempre più preminenti, e per la prima volta il processo costruttivo viene concepito come un processo collaborativo tra artigiani qualificati.
Francesca Gardino, La cappella del Santissimo Crocifisso in San Giovanni dei Fiorentini
Abstract: The Sacchetti Chapel in San Giovanni dei Fiorentini in Rome, dedicated to the Most Holy Crucifix and attributed to Carlo Maderno for its stylistic innovations, represents a masterful synthesis of architecture, sculpture, and painting. It stands as a unique element within the church, distinguished not only by its rich, cultured, and refined patronage but also by its role as a transitional work that bridges a lingering 16th-century modus operandi and the emerging innovations of the Baroque. This essay examines the chapel’s historical and constructive development, shedding light on its significance within this pivotal artistic period.
Ita: La Cappella Sacchetti a San Giovanni dei Fiorentini a Roma, dedicata al Santissimo Crocifisso e attribuita a Carlo Maderno per la sua carica di innovazione stilistica, rappresenta una sintesi magistrale tra architettura, pittura, e scultura. Si tratta di un elemento unico all’interno della chiesa, che si distingue non solo per la committenza facoltosa, colta, e raffinata ma anche per il suo ruolo di opera di transizione tra un modus operandi cinquecentesco e le innovazioni emergenti del Barocco. Questo saggio esamina lo sviluppo storico e costruttivo della cappella, illustrandone l’importanza all’interno di questo periodo artistico.
Roberto Ragione, La cappella di San Filippo Benizi in San Giovanni dei Fiorentini
Abstract: The paper focuses on the Chapel of San Filippo Benizi in the Church of San Giovanni dei Fiorentini in Rome. The chapel has a complex and troubled history. Initially under the patronage of the Firenzuola family and dedicated to Saints Simon the Zealot and Jude Thaddeus, it was later requisitioned by the Company of the Pietà, which changed its dedication; first to Saint Philip Neri and subsequently to Saint Philip Benizi. Eventually, the Guicciardini family assumed patronage of the chapel, linking it also to the Bardi da Vernio family.
Ita: Oggetto dell’articolo è la Cappella di San Filippo Benizi nella Chiesa di San Giovanni dei Fiorentini a Roma. La cappella ha una storia lunga e travagliata. Originariamente sotto il patronato dei Firenzuola e dedicata ai Santi Simone lo Zelota e Giuda Taddeo, fu poi requisita dalla Compagnia della Pietà, che ne cambiò la dedicazione: prima a San Filippo Neri e in seguito a San Filippo Benizi. Infine, i Guicciardini si assunsero il patronato della cappella, cosa che la associò anche ai Bardi di Vernio.
Serafina Cariglino, Francesca Lembo Fazio, La cappella della Madonna di Loreto in Sant’Onofrio al Gianicolo
Abstract: The Madruzzo Chapel, dedicated to Our Lady of Loreto and first documented in 1500, is one of five chapels in the church of Sant’Onofrio al Gianicolo in Rome. This article examines the spatial and architectural transformations of the chapel during the late 16th and 17th centuries, a period when it was adopted as a patrician shrine by the Madruzzo family. The family also commissioned significant renovations to its decorative program. By drawing comparisons with contemporary Roman chapels, the study proposes a hypothesis attributing one of the chapel’s most sophisticated late-16th-century interventions to the hand of Carlo Maderno, reflecting the stylistic maturity of the period.
Ita: La Cappella Madruzzo, dedicata alla Madonna di Loreto e documentata già nel 1500, è una delle cinque cappelle nella Chiesa di Sant’Onofrio al Gianicolo a Roma. Questo articolo ne esamina le trasformazioni storiche e architettoniche tra il tardo XVI e il XVII secolo, al tempo in cui fu adottata come cappella gentilizia dalla famiglia Madruzzo. La famiglia inoltre commissionò un importante rinnovo del suo programma decorativo. Comparandola a altre cappelle romane, lo studio propone un’ipotesi che attribuisce uno dei più sofisticati interventi tardocinquecenteschi alla mano di Carlo Maderno, come riflesso della maturità stilistica dell’epoca.
Susana López Verdú, La cappella della Pietà in San Pietro in Montorio
Abstract: The Chapel of the Pieta in the church of San Pietro in Montorio in Rome, commissioned by Pietro Cussida, a Spanish diplomat and trustee of King Philip III, exemplifies the link between the Iberian patronage and the Roman artistic scene of the early seventeenth century. This article explores the uncertainties of attribution associated with the making of the chapel, considering figures such as Giulio Mazzoni, Stefano Maderno and, in particular, Carlo Maderno, recognized as the most plausible architect. The scarcity of archival documentation continues to hinder a definitive resolution of the issue.
Ita: La Cappella della Pietà nella Chiesa di San Pietro in Montorio a Roma, patrocinata da Pietro Cussida, diplomatico spagnolo e confidente di Re Filippo III, esemplifica il legame tra il mecenatismo spagnolo e la scena artistica romana a inizio diciassettesimo secolo. Quest’articolo esplora le incertezze di attribuzione associate alla realizzazione della cappella, prendendo in considerazione figure come Giulio Mazzoni, Stefano Maderno e in particolare Carlo Maderno, identificato come più plausibile architetto. La scarsità di informazioni documentarie continua a ostacolare la definitiva risoluzione del problema.